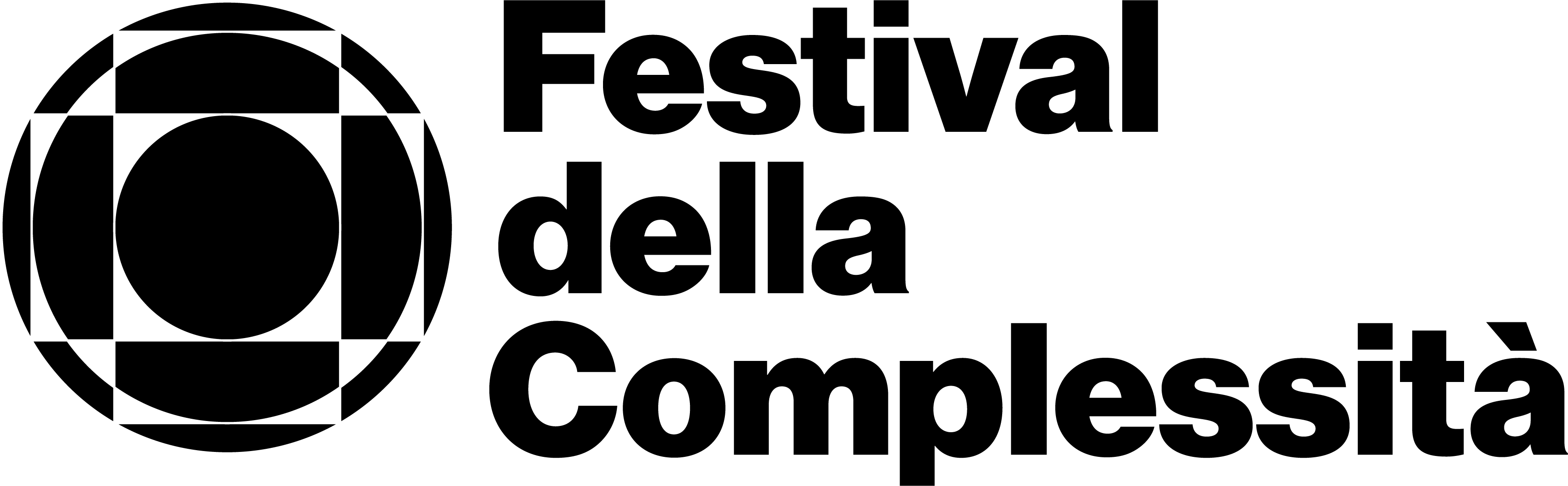La fatica della complessità.
I portici di Pordenone

Di notte a Pordenone, 20 Marzo 2018
Di Fulvio Forino
È sera, saranno le nove, per tornare in albergo passo dal corso di Pordenone. Cammino e, passo dopo passo, colonna dopo colonna, arco dopo arco, senza mai interrompersi, i portici m’accolgono e m’accompagnano lungo tutta la strada.
Poi lo sguardo va alle facciate dei palazzi. Molte sono intonacate e dipinte. Bellissime, parlano di medioevo, di cavalieri, del lavoro della terra, di bestie feroci. Altre, fatte di marmo, concepite per stupire, evocano linee e linguaggi rinascimentali. Le otto tozze colonne del portico di un vecchio teatro dalle linee dure che, prosaicamente classicheggianti, parlano chiaramente dell’ottocento.
Silenzio, in giro, nessuno. Qualche goccia di pioggia e un freddo, per me romano, pungente. Immerso in quell’atmosfera, carica di storia e di segni del tempo, vedo sbucare da una stradina due ragazzi neri, neri come la notte. Chiacchierano tra loro. Uno sguardo. Camminano veloci. Li vedo allontanarsi.
Poco dopo lui e lei, giovani, giovanissimi; cinesi. Avvolti in cappotti e sciarpe, mi vengono incontro. Leggeri, silenziosi, forse, con un leggero movimento del capo, accennano a un saluto. Ancora silenzio e freddo, rallento, mi fermo a osservare i capitelli delle colonne. Tutti diversi, alcuni sono molto suggestivi. Sono quasi alla fine del corso quando sento dei passi dietro di me. È una giovane coppia che mi supera a passo svelto. Con ogni evidenza sono magrebini. Belli, ben vestiti, lei spinge una carrozzina, lui le parla tenendola sotto braccio.
Per la prima volta penso: che ci fanno qui? Non riesco a collocarli, a trovargli un posto in questo posto dove sono piombati chissà da dove. Che c’entrano con la storia, con le tradizioni di Pordenone, e, come si diceva una volta, con i suoi usi e costumi? Come possono amare la polenta, il musetto, il frico, il radicchio che, onnipresente, sono costretto a mangiare in tutte le salse da tre giorni ?
Da dove vengono queste domande? A Roma incontro stranieri da ogni dove, frotte di cinesi, americani, russi, gente di ogni razza, lingua, nazione. Fanno parte del paesaggio. Non mi suscitano nessuna emozione. Mangio in ristoranti magrebini, cinesi, thailandesi, greci, messicani. Ma, penso, non sono nel caos di Roma. Non sono neanche in quella che era la tranquilla città dalla mia giovinezza. Oggi abito in una frenetica metropoli che, invasa e trasformata dal turismo, per la prima volta, mi appare come un non-luogo.
Sono qui, in un angolo di una qualunque città di provincia, in luogo che reca i segni della sua storia. Sono qui, dove tutto mi parla di una comunità, di una cultura che affondano le loro radici nel tempo. Per la prima volta penso che ci sia un qualche cosa che viene prima del razzismo, della xenofobia, della paura e del disprezzo per gli immigrati e per la loro diversità. Chi ho incontrato per strada in questa notte buia appena rischiarata dalla luce incerta dei lampioni: due ragazzi, presunti, africani; due adolescenti che ho etichettato come cinesi; una coppia di giovani sposi che ho astrattamente classificato come maghrebini. Maghrebini ? Arabi, berberi? Ma come? Non so che il Maghreb è più grande dell’Italia, che è un mosaico di nazioni, popolazioni e culture?
Forse c’è un qualche cosa che viene prima della difficoltà all’integrazione. Forse è la difficoltà dello straniero, dell’estraneo a collocarsi in un tessuto di storia, cultura, abitudini.
Certamente è la difficoltà che ho provato io; io, democratico, presunto aperto all’incontro e all’accoglienza. Certamente è la difficoltà a collocare il diverso nella storia propria di comunità coese, in qualche modo raccolte, spesso chiuse, nella propria cultura narrata da sempre uguale a se stessa. Certamente è la difficoltà che nasce quando siamo tentati dalla semplificazione; quando etichettiamo lo straniero, il diverso. Quando ne facciamo un’icona; quando lo riduciamo a un’astrazione così che non ci appare più come un qualche cosa di reale; come persona con cui noi, prima di lui, dovremmo essere capaci d’integrarvi.
Che fare? Che pensare? Come entrare in contatto con loro che sono a me così estranei e per i quali sono certamente estraneo? C’è un livello emotivo che ci impedisce d’accedere a loro; l’etichettare, l’astrarre l’altro, il farne un’icona senza anima e senza storia è frutto di una mia difficoltà. La soluzione più semplice consiste nell’averne paura. Non è l’orgoglio della propria cultura, né il coraggio di difenderla che generano rifiuto, xenofobia, razzismo bensì una paura automatica, inconsapevole e perciò fantasmatica e impossibile da discutere e gestire. È una paura che si autoalimenta di stereotipi: sono negri, sono irregolari, sono molti, troppi, sono delinquenti, parassiti. Come uscirne ? In alcuni casi sarà anche vero. Poi penso. Chissà, parlandoci? Magari, se avessi potuto parlarci, magari avrei scoperto che sono persone, che hanno un nome e cognome, dei sentimenti, delle ansie, delle speranze, delle difficoltà, del nuovo da consegnarci. Parlarci? Darmi la possibilità di entrarci in contatto?
Arrivo in albergo senza incontrare nessun altro. Vado a letto pensando alla saggezza del pensiero complesso che ci costringe a pensare a come pensiamo, al fatto che, come tutti gli esseri viventi, siamo “condannati” a stabilire relazioni. La relazione viene prima, stabilire relazioni, vere relazioni, ci salva. È l’unica via che conduce a soluzioni inaspettate, alla convivenza. Prendo atto della mia difficoltà. Rivendico il mio diritto a essermi sentito a disagio davanti a degli stranieri, a dei diversi incontrati in una buia notte in cui, in qualche modo, anch’io ero straniero.
A un tratto comprendo che l’alternativa a prendere consapevolezza della propria difficoltà è il razzismo facilone, la xenofobia, il rifiuto ostile e aggressivo. Comprendere la difficoltà di chi non sa e non riesce a collocare il diverso nella sua realtà non significa giustificare né risolvere. Può, però, farci accedere all’idea che c’è un prima, un livello emotivo, che rende difficile, e tanto meno automatico, per una comunità collocare lo straniero, così come il diverso, nella propria storia e nella propria cultura. Comprendere può aiutare a percorrere vie nuove, a contrastare gli untori della paura, a rivelare quanto ciò che essi spacciano per orgoglio e coraggio è solo frutto delle loro paure.